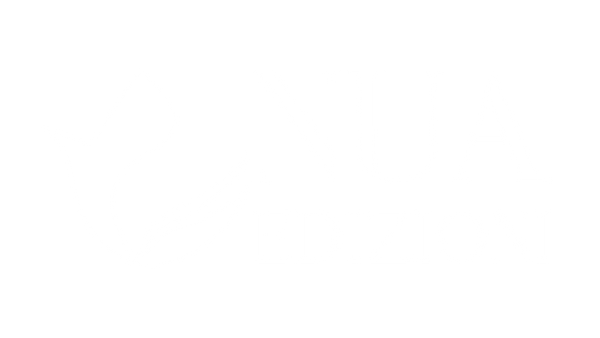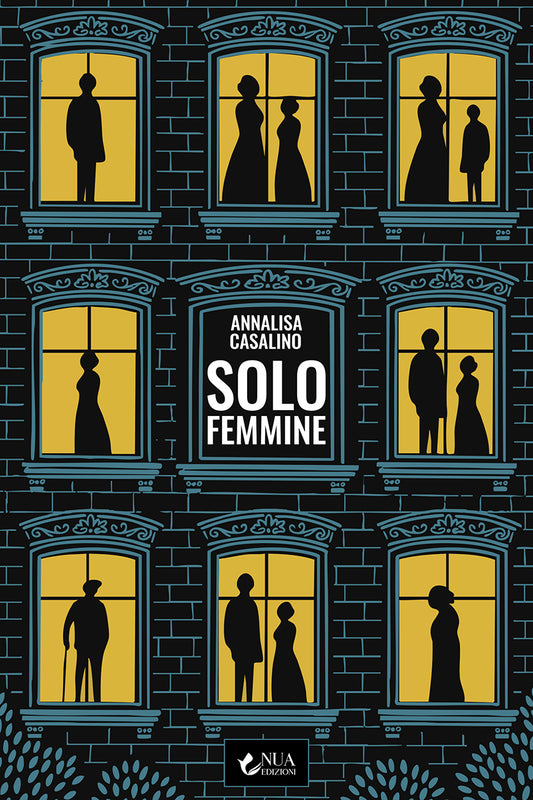Virginia Woolf: I demoni dietro la genialità. Un estratto da "Vita di una falena"
Share
Nel tracciare una biografia Virginia Woolf, è impossibile separare la vita dall’opera, l’esperienza privata dalla rivoluzione letteraria che ha segnato la letteratura inglese del Novecento. Nata a Londra nel 1882, Virginia Woolf crebbe in un ambiente colto e stimolante, ma profondamente segnato da rigide convenzioni sociali e da un’educazione diseguale tra uomini e donne. Proprio da questa frattura nasce la sua voce: lucida, radicale, capace di interrogare la condizione femminile e il ruolo delle donne nella storia con uno sguardo nuovo, mai accomodante.
La vita di Woolf fu attraversata da lutti precoci, crisi depressive e ricoveri, ma anche da un’intensa attività intellettuale. Attorno a lei prese forma il Bloomsbury Group, un cenacolo di scrittori, artisti ed economisti che contribuì a ridefinire il pensiero culturale ed estetico dell’epoca. In questo contesto, Woolf sviluppò una scrittura sperimentale che abbandonava la trama tradizionale per esplorare la coscienza, il tempo interiore, le zone d’ombra dell’identità.
Leggere la vita di Virginia Woolf significa dunque entrare nel cuore di un’epoca di trasformazioni radicali. Significa anche riconoscere il contributo decisivo di una scrittrice che ha saputo dare forma letteraria all’esperienza femminile, aprendo spazi di pensiero ancora oggi fondamentali per comprendere il rapporto tra identità, scrittura e libertà.
In Vita di una falena, Martina Tozzi non si limita a raccontare una biografia. Ci porta dentro la testa e il cuore di Virginia, dipingendo un ritratto intimo, doloroso e vivido di un'anima che è stata attratta dalla luce della creatività fino a bruciarsi le ali.
"Vita di una falena" di Martina Tozzi
Vita, amori e dolori di Virginia Woolf
Capitolo 1
Londra, 1886
Since a life has to begin with birth and to continue through the years these facts must be introduced in order. But have they anything to do with him ?
(V. Woolf)
«Ma i gatti neri ce l’hanno la coda?»
La vocetta infantile risuonò improvvisa nel silenzio ozioso della nursery. Virginia sobbalzò e si voltò in direzione della sorgente del suono, ovvero Nessa, sua sorella, sdraiata come lei sotto il tavolo della stanza calda e familiare. Esitò un attimo, il cuore che danzava nel petto. Era una domanda importante, rifletté Virginia, non poteva dare una risposta qualsiasi. Sua sorella maggiore chiedeva il suo parere su un argomento di massima rilevanza: doveva impressionarla, pensò, non poteva farsi sfuggire quell’occasione. Intorno, fruscii di gonne e il rumore della voce di Thoby, ma Virginia percepiva in quell’oscurità gli occhi chiari della sorella fissi su di lei, li immaginava vividi come due stelle, e non si lasciò distrarre. Serrò le palpebre, aggrottò le sopracciglia e provò a figurarsi davanti un gatto: ovvio che aveva la coda, osservò. Ma un gatto nero? I gatti neri erano differenti, erano speciali, lo sapevano tutti. E se si provava a immaginare un gatto nero, ecco che la coda spariva. Si concentrò ancora di più, si morse l’interno della guancia, dubbiosa. Nessa le stava concedendo tanta fiducia e non doveva sbagliare. E, in ogni caso, detestava sbagliare, lei.
«No,» decretò infine con un certo grado di sicurezza. «Non ce l’hanno.»
«Grazie, Ginny,» rispose Nessa prima di strisciare via, soddisfatta. «Sembrava anche a me.»
La benevola approvazione dell’amata sorella la fece galleggiare in quell’oceano oscuro sotto la tavola della nursery come in una nuvola di benessere e pace. Perché fare colpo su Vanessa – o Nessa, come la chiamavano tutti – era per lei una soddisfazione tanto grande da farla ondeggiare per l’emozione. In quanto penultima figlia di una famiglia numerosa, Virginia si doveva ingegnare per non passare inosservata, per ricavarsi un suo posticino dove poter brillare. E una delle sue principali aspirazioni, da quando aveva memoria, era conquistare l’amore e la considerazione di Vanessa, e si affannava in ogni modo per attirarne l’attenzione.
Adeline Virginia Stephen, questo era il suo nome, aveva quattro anni e tutto il suo mondo era la casa al 22 di Hyde Park Gate, a Londra. Nessuno la chiamava Adeline, anche se era il suo primo nome, lo stesso di una zia morta meno di un anno prima della sua nascita. La mamma aveva insistito per darglielo, proprio per onorare la sorella scomparsa tristemente per una malattia al cuore, ma si incupiva se sentiva parlare di lei, che se ne era andata mentre si trovava in una casa lugubre e tetra del Pembrokeshire, in Galles, e allora nessuno si rivolgeva mai alla piccola chiamandola Adeline. La chiamavano, invece, Virginia, e poi con una lunga sfilza di soprannomi: Gini, Ginia, Ginny, oppure bellezza – più spesso di tutti era papà a chiamarla così – ma anche capra, o capretta, da cui derivava Billy, da Billy la capra. Era il nomignolo che in assoluto veniva utilizzato di più, le era stato affibbiato durante una delle consuete passeggiate ai Kensington Gardens, quando per uno spiacevole incidente i mutandoni le erano scivolati alle caviglie, e lei si era sentita sopraffatta dall’imbarazzo, le paffute guance paonazze. Aveva perciò deciso di salvarsi dalla vergogna e si era gettata in un cespuglio per nascondersi, per poi esibirsi in un’interpretazione canora di The Last Rose of Summer per distogliere l’attenzione dalla faccenda della biancheria finita per terra: da allora, tutti la chiamavano capra.
«Ginia è pazza come una capra!» la derideva Thoby, che aveva un anno in più di lei e che per questo pensava di essere molto più intelligente. Thoby era un bambino vivace e caparbio, e Virginia lo trovava spesso irresistibile, ma era anche prepotente, e aveva la speciale capacità di mandarla su tutte le furie.
«Si vede subito quando ti arrabbi,» osservava Vanessa, con un’espressione grave sul viso. «Le guance ti diventano rosse, come fiamme, e gli occhi ti brillano in una maniera diversa dal solito. Sei bella, quando ti arrabbi, ma sei selvatica.»
Virginia sbuffava sdegnosa, a quelle parole. «E allora non fatemi arrabbiare,» rispondeva. Lei non aveva paura di nessuno, e sapeva come difendersi. Quando Thoby le faceva definitivamente perdere la pazienza, si scagliava contro di lui con tutta la sua forza. Spesso era lei ad avere la meglio, sia su Thoby che su Vanessa. Loro non accettavano mai di essere sconfitti da una bambina più piccola, però, e non facevano che lamentarsi.
«Mamma, papà, la capra mi ha graffiato,» piagnucolava immancabilmente Thoby confessando subito ai genitori quello che era successo. La mamma la rimproverava e scuoteva la testa.
«Una signorina dovrebbe mostrarsi un po’ meno dispotica,» osservava.
Papà la prendeva da parte e le faceva lunghe prediche sull’inappropriatezza di reagire alle provocazioni usando la violenza e graffiando come una belva feroce. A Virginia piaceva papà, perché non la trattava con condiscendenza ma con rispetto, come se fosse grande.
«Papà, ma allora perché abbiamo le unghie?» aveva chiesto Virginia sinceramente perplessa una volta. Papà era scoppiato a ridere e non aveva risposto, e Virginia si era tenuta quel dubbio, ma era stata contenta perché papà aveva un debole per lei, lo sapeva.
Una voce oltre l’oscurità la fece di nuovo emergere dai pensieri: era la voce di Stella.
«Nessa, Ginia, venite fuori: vi porto a spasso ai giardini!»
Senza farsi pregare, le bambine affiorarono da sotto il tavolo saltellando per l’entusiasmo. La passeggiata ai Kensington Gardens era il momento che preferivano delle loro giornate, ed erano sempre felicissime quando arrivava l’ora di uscire per quella che ai loro occhi appariva come una meravigliosa avventura. Al richiamo della sorella Stella, dunque, corsero immediatamente a vestirsi, aiutate dalla bambinaia che sistemò loro gonne e berretti, e in breve tempo furono pronte. Stella prese Virginia per una mano, Vanessa per l’altra e intimò a Thoby di starle vicino: erano pronti per la loro escursione giornaliera. Adrian, tanto per cambiare, era con la mamma: era il suo preferito, la sua gioia, come amava ripetere lei, e Virginia fece una smorfia riflettendo su quanto disgustosamente la mamma lo viziasse.
La loro casa era molto vicina ai Kensington Gardens, il luogo delle scorribande dei piccoli Stephen e dove la mamma amava ambientare i suoi racconti. Era una casa alta, poco luminosa, con tante stanze colme di mobili, soprammobili e tende, con numerosi quadri e fotografie alle pareti: una zia della mamma era Julia Margaret Cameron, la fotografa, che era morta prima che Virginia nascesse. I mobili, di legno scurissimo con i dettagli sottolineati da una grave vernice dorata, erano ricoperti da velluti rossi, e la mamma era molto orgogliosa dell’effetto austero che conferivano alle stanze dalle pareti blu notte. Alle finestre, pesanti panneggi impedivano al sole di entrare. Quando furono in strada, i piccoli e Stella vennero inondati dalla luce gioiosa di aprile: sembrava un altro mondo.
«Sai, Ginia?» bisbigliò Vanessa avvicinandosi all’orecchio della sorellina. «Vorrei essere sempre immersa in questi colori. Quando sarò grande, la mia casa sarà tutta bianca.»
Virginia si sentì immensamente colpita da quelle parole, e le parve che ricevere quella confidenza avesse reso il suo rapporto con Vanessa ancora più stretto e importante. Si sentì attraversare dal piacere, consapevole che quell’affermazione così audace sottintendeva una critica alle scelte della mamma, della loro perfetta mamma Julia, e si sentì unita alla sorella come una cospiratrice.
Il parco era molto vicino, e ci voleva davvero poco a raggiungerlo. Ma bisognava prestare attenzione, lungo la strada, alle carrozze, e Virginia teneva stretta la mano di Stella per non rischiare di essere travolta da un cavallo: era meglio essere prudenti.
La via in cui vivevano era tranquilla, e bella, pensava Virginia, ogni casa era differente e la loro, stretta e familiare, era la più preziosa ai suoi occhi. A differenza di altre famiglie del quartiere, loro non possedevano una carrozza, e solo in occasioni eccezionali ne noleggiavano una: andavano quasi sempre a piedi o, se volevano raggiungere zone più lontane della città, usavano gli omnibus. La mamma si muoveva per tutta Londra per andare a fare del bene alle persone bisognose, ed era bravissima a cavarsela con i mezzi pubblici. Prendeva l’omnibus rosso e poi saltava su quello blu, e poi ancora cambiava per passare a quello giallo: si destreggiava con maestria tra tutte le linee e non si confondeva mai. Quando portava con sé Virginia, lei si sedeva al suo fianco e si sentiva molto grande e molto orgogliosa di stare insieme alla mamma.
In pochi minuti raggiunsero il parco. Un passo oltre il cancello verniciato di fresco, un’occhiata furtiva alla vecchia avvolta in uno scialle nero che vendeva palloncini rossi, blu e viola – si potevano comprare per un penny, a Virginia piacevano tanto, ma solo quando si comportavano molto bene avevano il permesso di acquistarne uno – ed erano entrati in un altro mondo. Lì non c’erano solo adulti con le loro facce serie e i vestiti scuri, ma tanti bambini che correvano, e cani che abbaiavano allegramente. Virginia si beò dei colori della primavera, degli odori degli alberi e dei cespugli fioriti, ascoltò il cinguettio degli uccelli. Era felice. Dopotutto la mamma lo diceva sempre: non sarete mai più felici come adesso, bambini miei. Forse era vero.
Giocarono, corsero insieme, si sporcarono i vestiti, e poi presero a passeggiare con Stella per i sentieri circondati dai fiori che iniziavano a sbocciare. Raggiunsero il Round Pond, dove spesso si divertivano a far galleggiare le barchette, e poi il sole iniziò a scendere e l’aria a tingersi di rosa e arancio. Era tempo di rientrare, così Stella richiamò i bambini e insieme iniziarono a saltellare al suo fianco percorrendo all’indietro la strada che avevano già calpestato. Quando arrivarono vicino all’Albert Memorial, Virginia si fermò un momento a fissare l’elegante monumento. In cima a una scalinata, sotto un ricco baldacchino che correva verso il cielo come una rapsodia, splendeva alla luce ormai arancione del tardo pomeriggio la statua dorata del principe Alberto, che era morto molto prima che lei nascesse ma che la regina ancora piangeva. Dovevano essersi amati proprio tanto, pensò Virginia con curiosità. Era curiosa di tutto, anche dei sentimenti della gente.
«La mamma è stata triste quanto la regina Vittoria quando è morto il signor Duckworth?» domandò improvvisamente.
«Oh, che domanda, Ginia! Come faccio a paragonare il dolore di due vedove?» rispose Stella dopo un momento di riflessione. Stella non rispondeva mai tanto per rispondere, e Virginia si fidava di lei. «Non posso giudicare la sofferenza della regina, ma so che la mamma è stata molto, molto triste. Diceva di aver conosciuto la gioia più grande, e subito dopo il più grande dolore. La morte di papà è stata la cosa più terribile di tutta la sua esistenza, ed è stata così repentina! Un attimo prima si allungava per cogliere un fico per lei, e l’attimo dopo giaceva per terra in preda agli spasmi, e poi è morto, così, inaspettatamente. Una cosa del genere ha sconvolto la mamma, e l’ha cambiata, anche. Prima credeva in Dio, ed era molto devota. Ma quando papà se ne è andato, tutte le sue certezze sono crollate, e non poteva scorgere un senso nel suo dolore, un senso divino. Solo una disperazione profonda può spingerti a mettere in discussione tutto quello che ti hanno insegnato, e lei l’ha provata. E ha perso la fede.»
«Infatti noi non siamo battezzati,» intervenne Thoby con fare intelligente, mentre riprendevano la passeggiata.
«Papà avrebbe trovato la cosa ridicola,» proseguì Vanessa, ripetendo quello che aveva sentito pronunciare dalle domestiche di casa.
«La mamma singhiozzava per intere giornate, quando papà è morto, e quasi non riusciva a scendere dal letto,» riprese Stella, che quando suo padre era scomparso aveva solo tre anni e quelle storie le conosceva dai racconti dei parenti. «Gerald è nato un mese dopo, e la mamma non riusciva a riprendersi neanche con quel nuovo bambino da accudire. Vestiva di nero, piangeva sempre… Aveva solo ventiquattro anni, povera mamma, e amava così tanto papà! Non c’è mai stato un amore come il loro, ne sono sicura.»
Virginia annuì, pensosa, guardando la sorella maggiore. Aveva gli occhi chiari e il volto allungato ed era molto bella, non come la mamma, forse, ma molto, molto bella.
«Ero piccola, a quei tempi, ma una cosa la ricordo bene. La mamma andava sempre al cimitero, e mi portava con sé, qualche volta. E si distendeva sulla tomba, a Orchardleigh, si metteva sdraiata, le braccia allargate come in croce. E piangeva.» L’immagine appariva vivida agli occhi di Virginia, ma era familiare, perché Stella raccontava spesso quel particolare. «Pregava di morire presto anche lei, per raggiungerlo.»
«Oh,» si lasciò sfuggire Thoby, orripilato al pensiero che, se la mamma fosse davvero morta, loro non sarebbero nati.
«E poi? E poi?» domandò Virginia, desiderosa di arrivare al momento in cui in scena entrava papà.
«E poi la mamma incontrò vostro padre, il signor Stephen,» riprese Stella con la sua voce rassicurante, i capelli chiari che brillavano colpiti dai raggi del sole che spariva dietro l’orizzonte. «E il resto lo sapete.»
«Sì,» annuì Vanessa. «Siamo nati io, Thoby, Ginia e Adrian.»
La famiglia era in realtà più complicata di così, pensò Virginia osservando un piccione che andava a posarsi su uno degli angeli dorati del raffinato baldacchino del principe Alberto. Perché sì, c’erano loro, i quattro fratelli Stephen: Vanessa, la sua preferita, che adorava senza ritegno, ma della quale era anche costantemente gelosa, che aveva quasi sette anni; Thoby, di cinque anni e mezzo, che Vanessa riveriva in maniera disgustosa; poi lei, Virginia, di quattro anni; e infine Adrian, che in ottobre ne avrebbe compiuti tre. Ma sia la mamma che il papà erano vedovi, e a casa c’erano anche i figli della mamma, i ragazzi Duckworth: George e Gerald, di diciotto e sedici anni, che andavano a scuola ed erano grandi, e Stella, che aveva diciassette anni ed era bella, gentile e molto buona.
La mamma la prendeva in giro per la sua mitezza e la chiamava Vecchia Mucca, e allora certe volte anche i fratellini la chiamavano così. La mamma era più paziente con George e Gerald che con Stella, pensava Virginia, ma forse era normale perché loro erano maschi e la mamma trovava la cosa molto speciale, per qualche ragione che lei non comprendeva; probabilmente da grande lo avrebbe capito. I Duckworth erano differenti rispetto a loro, gli Stephen. Ai suoi occhi di bambina sembravano quasi divini, di una specie lontana, irraggiungibili. Per scherzare, papà aveva detto una volta che i piccoli Stephen si riconoscevano subito, perché nascevano con la coda. Era uno scherzo buffo ma Virginia ci pensava spesso. Lei era una Stephen, non una Duckworth, e lo sapeva: non faceva parte del loro gruppo.
Anche papà era vedovo, quando aveva sposato la mamma. La sua prima moglie si chiamava Minny ed era morta per qualcosa che riguardava una gravidanza, ma anche lei aveva lasciato a papà una bambina, la sua figlia maggiore, Laura, che era nata troppo presto ed era piccolissima quando era venuta al mondo, come una minuscola bambolina. Forse era per questo che non era come gli altri: anche se aveva l’età di Gerald, Laura si comportava ancora come se fosse piccola quanto Adrian. Non sapeva scrivere e leggeva male, anche se Thoby sosteneva che gli avesse letto tutta Alice nel paese delle meraviglie, ma probabilmente se lo era inventato per impressionare le sorelle. Laura era una creatura misteriosa, imbronciata e spettinata, e Virginia non la conosceva bene: non passava tanto tempo con loro, infatti, non entrava mai nella nursery e stava quasi sempre nella sua camera. Si univa alla famiglia solo per i pasti, perché papà ci teneva che fossero tutti insieme. A Virginia, Laura non piaceva: aveva lo sguardo perso da qualche parte dove loro non potevano sbirciare, e continuava ininterrottamente a borbottare parole senza senso. Ogni tanto, i bambini le facevano qualche scherzetto – come quella volta che le avevano detto che aveva tutta la faccia sporca quando non era vero, e lei si era strofinata vigorosamente per un bel pezzo, fino a che la guancia non le era diventata rossa e qualcuno, Stella, forse, era andato a fermarla – ma la mamma li rimproverava e li accusava di essere crudeli. Virginia sapeva che neanche a papà piaceva Laura, una volta lo aveva udito dire tra sé e sé: «Bambina mia, perché sei così? Non troverai mai nessuno disposto ad amarti.»
E chi avrebbe potuto amarla? Virginia la osservava, qualche volta, durante le cene, che faticava a mandare giù un boccone e quasi soffocava nel suo cibo. La mamma si spazientiva, alzava gli occhi al cielo, accusava Laura di essere maleducata e selvaggia. Lei non si preoccupava dei rimproveri, delle minacce di essere punita, continuava imperterrita, sputacchiava il boccone mezzo mangiucchiato e riprendeva il suo monologo borbottato sottovoce.
«Io gli ho detto di andare via, gliel’ho detto, vai via.» Ma poiché non la capiva, Virginia si stancava di ascoltarla e voltava la testa altrove.
>> "VITA DI UNA FALENA" È DISPONIBILE IN CARTACEO E DIGITALE <<