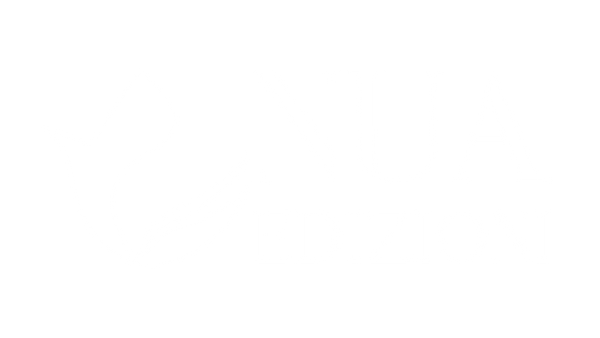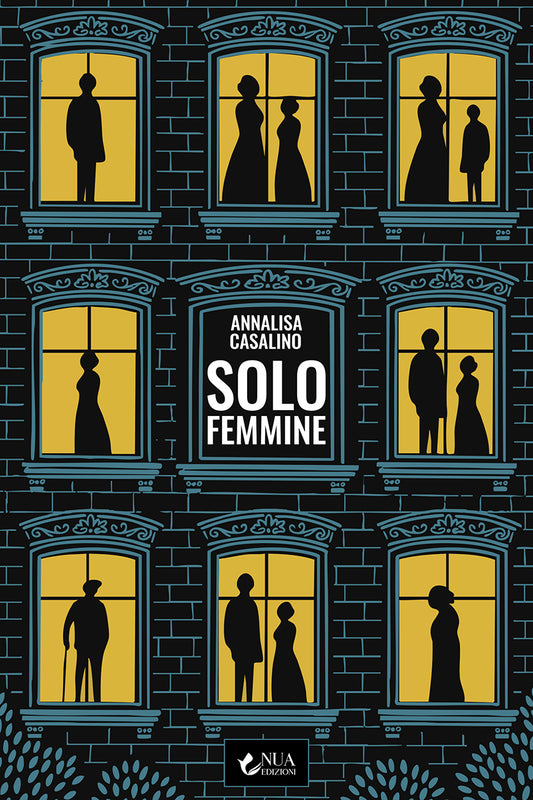Leggi il 1° capitolo di "Marmo e Fango"
Share
"Marmo e Fango - Amore e possesso nella Roma di Gian Lorenzo Bernini" di Alessandra Giovanile.
Il passeggino bianco
Capitolo 1
A.D. 1629
Le sembrava che ormai fossero un tutt’uno: la sua gota appoggiata alla mano sinistra, sospinta verso l’alto dal peso della testa contro il palmo, la tempia calda che pulsava leggera contro i polpastrelli, il plip-plop irregolare delle gocce contro la finestra.
Era un pomeriggio interminabile di pioggia insistente e la luce fioca non riusciva a filtrare dal vetro opaco, piombato a piccoli cerchi. In casa regnava una generale sonnolenza: all’altro capo del tavolo Tiberia strizzava gli occhi, ciondolando sul suo lavoro di cucito, e anche i bambini avevano abbandonato i giochi più movimentati per cercare di far rotolare due noci in un corridoio di cucchiai di peltro allineati sul pavimento.
Costanza sentiva i piedi gelati nelle pantofole, ma non era ancora il momento di ravvivare il fuoco che languiva. «Un altro giorno di pioggia… Credi che il Tevere romperà gli argini?»
Tiberia sbuffò, tagliando il filo con i denti. «Se trabocca noi saliamo ai piani alti.»
Era suo padre Leonardo, il marito di Tiberia, a dir sempre così da quando, grazie ai suoi servigi di staffiere, si erano trasferiti nelle tre stanze al pian terreno del palazzo Morada di Alfonso Manzanedo de Quiñones, gran promotore della causa della Serafica Vergine Santa Teresa del Gesù. Il suo era un buon lavoro, che non faceva mancare il pane al desco e grazie al quale non dovevano pagare l’affitto per una sistemazione ben più modesta di quella. Ma c’era sempre qualche imprevisto che faceva sì che del suo salario non restasse molto e infatti Tiberia si cavava gli occhi nel rammendare e rifinire un gran numero di commesse da diverse botteghe di sartoria. Più di una volta aveva cucito l’orlo di un ferraiolo[1] porpora, eppure il cardinale in questione non avrebbe mai saputo che tre paia di mani infantili avevano accarezzato quella seta liscia e lucida.
Non bastava il lavoro di Leonardo Piccolomini per comprare le scarpe a Michelino, né per far bruciare legna di giorno, a ormai solo due settimane alla Domenica delle Palme. Il lavoro di staffiere non bastava neppure a maritare bene una figlia, Costanza, ma per quello esistevano le doti per le zitelle oneste.
«Tiberia, c’è davvero bisogno di richiedere un’altra dote?» domandò lei.
Le rispose la piccola Cecilia, che ancora non aveva imparato l’uso del vasino, con un urletto acuto.
Tiberia sollevò la piccina da terra e gliela porse. «Ci pensi tu? Io devo finire una riparazione che era da consegnare ieri.»
Cecilia emise un risolino mentre Costanza la faceva sedere sul tavolo e le sfilava la camicina infradiciata, lanciando intanto un’occhiata a Michelino che continuava a giocare sotto il tavolo.
«Tiberia, la mia era una domanda seria. Ho già ottenuto la dote della Confraternita di San Rocco, che è una delle più generose.»
Era così, solo dieci tra le zitelle più meritevoli e segnalate come integerrime dalla comunità potevano vantarne l’assegnazione. E il Ferragosto passato le era stata conferita la pergamena con il suo nome aggiunto a mano e, in fondo, la firma del cardinal Borghese. Era stata riposta nella credenza con l’attenzione che sarebbe stata riservata all’ostia consacrata nel tabernacolo. La Confraternita ne conservava una copia che le avrebbe fruttato il pagamento o che sarebbe stata stracciata nel caso avesse perduto l’onore per un comportamento inopportuno. Possibilità assai remota, dal momento che erano già due anni che era reclusa in casa.
Roma era pericolosa, ma certi giorni Costanza credeva che se non fosse uscita alla luce del sole sarebbe diventata cieca come le talpe in fondo alla tana.
«Dunque a che serve un’altra dote?» riprese a insistere.
«Pensi di attirare un marito con due braccia e due gambe, facendo leva su quarantacinque miseri scudi?»
Lei rimase in silenzio: con quarantacinque scudi, aveva sentito, ci si pagava l’affitto di una casa per un anno, anche se forse non una delle più dignitose.
«Un marito decente, e non decrepito, lo trovi se hai i soldi per pagargli almeno l’avvio di un’attività,» aggiunse Tiberia.
«Non basterebbe l’affitto per un anno della sua bottega?»
Tiberia le lanciò un’occhiataccia, mentre proseguiva nel suo ragionamento. «Oppure lo acchiappi se sei molto bella.»
Non era il suo caso, pensò lei.
«E se sei furba, ma non è il tuo caso.»
Sapeva a chi si riferiva Tiberia. Giustina, a tre portoni dal loro, si era fidanzata a dodici anni: un’autentica meraviglia con una corona di riccioli neri e gli occhi verdi e sfuggenti come l’acqua della Barcaccia.
Ma Tiberia diceva anche che a Roma di uomini ce n’erano troppi e che bisognava stare in guardia da chiunque avesse l’uccello nelle braghe, perché dalle braghe volava via facilmente. Quelle che non erano furbe finivano ingravidate senza essere sposate e allora erano guai grossi per tutto il parentado.
Perché il fango era facile ad attaccarsi: avrebbe sporcato i genitori, i fratelli e soprattutto le sorelle che non avrebbero più contratto un matrimonio onesto. Come quando il Tevere si ritirava dopo essere uscito dal suo letto, la vergogna lasciava una mota sabbiosa e ci volevano anni per lavarla via del tutto.
Prima che Costanza nascesse, ben prima che suo padre arrivasse a Roma, nel Natale del Novantotto, il Tevere era arrivato fino alla piazza del Pasquino[2]: ancora le case laggiù portavano una riga di sfregio.
Tiberia non pronunciava mai il nome proibito, ma Costanza aveva la sensazione che il fantasma della propria sorella aleggiasse nell’aria, quando si facevano quei discorsi. Eppure, anche intuendo che la perduta Anna Maria c’entrasse con quella fanghiglia, l’idea di essere disonorata a Costanza sembrava una possibilità remota.
I tanti uomini di Roma guardavano le ragazze con i riccioli bruni e il seno già formato, non certo lei che a quindici anni era piatta come un’asse da far ponteggio. E se anche qualcuno si fosse accontentato, doveva scovarla: a Viterbo aveva frequentato per tre mattine a settimana la scuola del catechismo, ma ora, nel rione Colonna, passava la gran parte della giornata chiusa al palazzo de Manzanedo, se non si teneva conto delle brevi evasioni per le piccole spese quotidiane quando la sua matrigna era impegnata a finire un lavoro di cucito, e sempre scortata da Michelino appeso alle sue gonne.
«Non sognarti di ricambiare lo sguardo di un uomo,» diceva Tiberia, mentre le affidava i baiocchi per il pane e il formaggio, quando, prima della nascita di Cleria, aveva un pancione che faceva sembrare le sue gambe corte e sgraziate e non poteva fare tre passi senza inciampare nei suoi piedi.
Non che a Costanza interessasse. Si era accorta che i soldati che bighellonavano davanti all’arco di Portogallo la guardavano, ma ne aveva ricavato molta vergogna e nessun piacere. Si era tirata il fazzoletto più avanti sulla fronte e aveva trascinato più lesta Michele, ma quegli sguardi le erano rimasti appiccicati addosso come una scia nauseante, come se le fosse caduto sull’abito un frutto mezzo marcio.
Era comunque meglio non attirare lo sguardo di nessuno: gli ispettori della Confraternita di San Rocco osservavano le destinatarie di dote per due anni dopo l’assegnazione provvisoria e se qualche invidioso avesse messo in giro voci false su di lei avrebbe perso i quarantacinque scudi, ma soprattutto l’onore. I pettegolezzi e gli scandali, anche quelli infondati, viaggiavano veloci tra i vicoli. Di bocca in bocca, di confraternita in confraternita, fino a rovinare persino le innocenti.
Nonostante la sua integrità, di ripercorrere la trafila per ottenere una seconda dote Costanza proprio non ne aveva voglia.
Gli ispettori erano arroganti, puntigliosi su ogni parola pronunciata. Pareva che godessero nel mettere a disagio le fanciulle e quelle che ne sapevano meno della vita, disabituate alla dialettica, rischiavano di compromettersi con una risposta affrettata.
Poteva essere il suo caso: se al catechismo era stata lodata per la velocità con cui aveva imparato a leggere e scrivere, quella del parlare era tutt’altra questione. A volte era difficile farsi capire, erano molti i pensieri che le affollavano la testa, ma trovare le parole corrette per esprimerli non le era facile. Avrebbe voluto dire, ad esempio, che non trovava giusto che gli uomini pretendessero di essere pagati quando prendevano una giovane donna in moglie: ottenevano già una serva in casa, o alla meglio una governante che comandasse i servi perché ci fosse in tavola la cena pronta all’ora giusta, volevano anche il denaro? E da Giustina aveva sentito che gli uomini sposati non andavano più nelle taverne di malaffare a cercare le donne, perché certe cose le potevano fare in casa. Senza contare che erano le mogli a figliare e a dare seguito al nome del marito e non al proprio. Insomma, per gli uomini c’era solo guadagno. E comunque, con tutti quelli che c’erano a Roma, e le poche donne al confronto, avrebbero dovuto essere loro a fare un’offerta sostanziosa per accaparrarsene una. Non il contrario.
Ma quando aveva tentato di spiegarlo a parole, aveva rimediato uno schiaffo sulla bocca da Tiberia. «Vorresti essere pagata come una meretrice?»
Un’altra ragione per la quale non era ansiosa di cercare un’altra dote era che, senza, il matrimonio avrebbe aspettato. Suo padre aveva detto che non intendeva farla sposare troppo giovane e anche Tiberia doveva essere stata d’accordo: c’era bisogno di qualcuno che si prendesse cura dei suoi figli.
A Costanza non pesava affatto: i piccoli erano tre putti adorabili ai quali si poteva solo imputare di avere sempre fame. Cleria, l’ultima arrivata, aveva quattro mesi e si attaccava ancora alle zinne della madre. Gli altri due tenevano quasi sempre la loro manina fresca e appiccicosa nella sua e non avevano che rari capricci con cui tediarla.
Quando Tiberia era entrata nella loro vita, Costanza e suo padre erano da poco rimasti soli. La prima moglie di Leonardo era morta da tempo, ma finché insieme a loro c’era stata l’adorata Anna Maria, sorella carnale, Costanza non aveva mai sentito la mancanza di una madre.
Anna aveva solo quattro anni più di lei, ma era capace di far tutto; non conosceva timidezza ed era veloce a imparare.
Costanza non ricordava un mutamento improvviso in sua sorella. Se c’era stato, lei era ancora troppo piccola e ingenua per accorgersene, ma un giorno suo padre l’aveva presa da parte e le aveva detto: «Dobbiamo dimenticare il suo nome, lei è morta per noi.»
Non aveva compreso, aveva chiesto cosa fosse successo e se la sorella avesse bisogno d’aiuto. Ma il padre aveva risposto secco: Anna era perduta e la migliore cosa per loro era credere che fosse in cielo come la mamma.
Leonardo in quelle settimane era sembrato impazzire di dolore. Più di una volta l’aveva visto piangere, ma lei non aveva avuto il coraggio di chiedere altre spiegazioni.
Dopo appena un mese si era preso in casa una donna di fuori Viterbo che già aveva una figlia, Maria Felice. Era uno scricciolo pallido e smunto di un anno più piccola di Costanza e che, a scapito del suo nome, teneva sempre il muso.
Tiberia era rimasta con loro per diversi mesi nella posizione ambigua della concubina. Un giorno Leonardo era tornato a casa con la nonna Marzia e tutte le sue cose su un carretto preso a nolo. Tiberia aveva fatto un gran fracasso, rompendo in terra alcuni piatti che erano stati della mamma, ma doveva aver ottenuto quello che desiderava. Nel giro di due settimane, nel giorno in cui compiva undici anni, Costanza si ritrovò a intrecciarle i capelli per la cerimonia di nozze.
Infine, quando erano arrivati a Roma, dietro San Lorenzo in Lucina, Tiberia aveva l’agognato rango di moglie rispettabile e Maria Felice era diventata la sua sorellina, anche se pareva una bambola di pezza, tanto era timida e silenziosa. A causa dell’aria fetida della città la piccina era presto volata in cielo, ma nel giro di pochi anni altri tre bambini di Tiberia ne avevano preso il posto.
Costanza smaniava ogni volta per quegli occhi dalle pupille enormi, quelle boccucce senza denti e le testoline che parevano rivestite di velluto fine. Glieli aveva cresciuti lei, due di quei tre diavoletti, ogni volta aspettando il seguente come se fosse la notte dell’Epifania.
«Questa è l’ultima,» le aveva detto la matrigna, dopo la nascita di Cleria. Una febbre aveva lasciato lei con pochi capelli e suo padre smunto e secco come un chiodo dalla preoccupazione. «I prossimi li sforni tu.»
Durante gli ultimi mesi Tiberia era tornata in salute, ma non aveva cambiato idea. «Quando ti sposerai ne farai quanti il Cielo ve ne manderà. Io ho già patito troppo con Maria Felice.»
E Costanza pensava che per la sua prima figlia doveva davvero essersi spremuta come una spugna, se poi quasi non le erano rimasti baci e carezze per gli altri tre piccini.
«Mi hai sentita, Costanza? Con una nuova dote, avrai più di quello che ho avuto io.»
«Non ti è andata male con mio padre,» protestò lei.
«Tuo padre è un brav’uomo, ma lavora da servo. E tu avrai di meglio rispetto a un mucchio di colletti da rivoltare. Tu e le altre,» fece Tiberia, indicando con un cenno delle sopracciglia Cecilia sopra il tavolo e Cleria nella culla. «Le donne non possono decidere di fare il bottaio o il doratore o il barcarolo. Devono seguire quello che fa il marito. Qualche figlia d’artista potrà anche diventar pittora di questi tempi, ma per le femmine quelli non sono mestieri onesti.» Levò gli occhi al soffitto. «Ti comporterai bene finché non uscirà il bando dell’Oratorio del Gonfalone. E quando avrai ottenuto una seconda dote farai un buon matrimonio e vivrai da Signora per il resto della vita.»